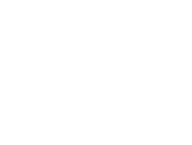La chiesa parrocchiale di Casteldidone
PRIMA DELLA CHIESA ATTUALE
Sulle terre emergenti di Casteldidone, ovvero il Mot, suolo matildico fortificato, è probabile che esistesse una cappella curtense e che essa fosse consacrata ai santi martiri persiani Abdon e Sennen, dato che proprio in quel periodo storico vennero rinvenuti i loro corpi santi (anno 960).
Quella che venne abbattuta per erigervi l'attuale, era però una chiesa più tarda, costruita, secondo quanto afferma don Palmiro Ghidetti (già parroco di Casteldidone) nel 1433, ubicata sopra un' altura artificiosa, a tre metri dal piano stradale. Era ad una sola navata, coperta a capriate, con due cappelle laterali che le facevano assumere l'aspetto di croce; la sagrestia era coperta con travetti e tavelle; le fondamenta, in pilastri ed archi, erano assai profonde ma il fondo era composto da materiale di cattiva qualità, per lo più da sedimentazioni di costruzioni precedenti. Questa descrizione la leggiamo nel libro del 1965 del parroco don Emilio Mazzani sulla chiesa di Casteldidone. Egli ci dice anche che coro e presbiterio erano angusti, che la chiesa presentava screpolature in ogni senso, che le assi del soffitto attaccate con chiodi al di sotto delle travi erano cadenti; inoltre l'area antistante la chiesa era in buona parte occupata da una casa colonica con torchio d'olio di proprietà del conte Schizzi e da orti annessi.
Erano questi motivi sufficienti per elaborare sulla chiesa, nel terzo decennio dell'ottocento, ben tre progetti in 12 anni?
LA NUOVA CHIESA: UN PROGETTO DOPO L'ALTRO
Si sa che la vecchia chiesa era ormai fatiscente, ma non del tutto irrecuperabile se tra le varie ipotesi ce ne fu anche una che prevedeva di recuperarla e ingrandirla. Ma questo primo progetto di restauro e ampliamento di Giuseppe Boccalari, un ingegnere di Piadena, non va a segno: troppe difficoltà, osservazioni, modifiche e costi insostenibili.
L'idea di una chiesa nuova si fa dominante allorché si pensa che la nuova costruzione sarebbe più capiente, adeguata alla popolazione che allora contava 1300 anime, urbanistica mente più corretta e scenograficamente diretta perché disposta di prospetto alla via principale del paese. Così il secondo progetto, dell'ing. Carlo Brilli di Cremona, prevede una nuova costruzione con facciata verso la via maggiore; ma il tracciato non permette un perfetto allineamento con la via principale, si invade uno stradello di accesso alla cascina Bolzesi, l'abside risulta troppo addossata al granaio della cascina, le dimensioni sembrano piccole e si fanno le prove coi banchi che vengono allineati tra le mura che stanno sorgendo; proprio relativamente alla capienza, il progetto non offre precise garanzie alla popolazione, decisa a realizzare ad ogni costo una chiesa grande e spaziosa; si boicottarono così i lavori già iniziati dall'ing.
Brilli: si abbatte di notte quel che si fa di giorno.
Si consulta Luigi Voghera e gli si affida l'impegno di disegnare un nuovo progetto, il terzo.
Luigi Voghera era l'architetto che in zona andava per la maggiore a quei tempi e in loco trovò consensi che, nonostante le ingenti spese e la scarsissima disponibilità di fondi, gli permisero di tracciare le fondamenta del nuovo edificio nell'ottobre del 1835, di terminare i lavori già nel 1837 e di procedere al collaudo nel 1838.
I Casteldidonesi, finalmente, trovarono piena rispondenza alle loro esigenze nel nuovo progetto dell'architetto cremonese che, ripristinando l'impostazione assiale est-ovest, potè fruire di uno spazio congruo che lo facilitò nella progettazione della chiesa e anche nella successiva impostazione dell'enorme e robusto stelo del 'campanile (su nuove fondamenta di 37 metri a fronte dei 18 m. del campanile vecchio).
Durante il periodo di costruzione della nuova parrocchiale, cioè dal 1835 al 1837, i casteldidonesi, grazie alla disponibilità dei Conti, la domenica andavano a messa a Palazzo, cioè al castello, nell'oratorio di S. Antonio, allungato con una costruzione in legno, mentre ci si serviva per i giorni feriali, battesimi e funerali, della Camera dei Confratelli, contigua al campanile.
Il 25 ottobre del 1891 il vescovo Geremia Bonomelli consacrò la chiesa e l'altare maggiore.
LA CHIESA OGGI
La chiesa, su base rettangolare, è lunga m. 40,75 e larga m. 12, che arrivano a 18 nel punto in cui assume l'aspetto di croce e si impostano i pilastri a sostegno della cupola che è alta ben 19 m.; lo spazio si ricompone poi nel presbiterio e nella curva del catino absidale.
In capo al transetto due ariosi altari dedicati a S. Giuseppe e alla Vergine del Rosario, preceduti dalle sei cappelle della navata che è chiusa da una imponente volta a botte.
La decorazione murale, di epoca più tarda, ma sempre abbastanza rispettosa dello stile neoclassico, è vivificata dalla luce che proviene dai finestroni semicircolari e, in particolar modo, dal lucernario della cupola: è questo fascio luminoso che, rischiarando ogni superficie, si fa protagonista dell'intero complesso architettonico.
All'esterno le superfici definiscono volumi precisi e si distendono in grandi campiture coprendo anche la curvatura della cupola, mentre si animano con compostezza e sobrietà nella facciata dove alternano, con armonia classica, gli elementi architettonici nel loro gioco cadenzato: vi si aprono tre ingressi racchiusi tra gigantesche semicolonne ioniche che frenano il loro slancio al di sotto della trabeazione e del frontone triangolare.
Il campanile, dopo un'interrotta corsa verso l'alto, si articola nelle quattro aperture della cella campanaria che richiamano lo schema compositivo della facciata; sopra le quattro edicole con timpano si imposta un tamburo ottogonale che sorregge la cupoletta di copertura.
Per quanto riguarda la parte pittorica, le cappelle e il catino absidale sono state decorate più tardi rispetto alla costruzione e sono opera di Francesco Rocca di Rivarolo Fuori che vi lavorò dal 1877 e terminò nel 1886, come si può leggere dalla firma e dalla data che compaiono sul messale aperto nel medaglione di centro; nella volta del presbiterio compaiono simboli liturgici, nelle cappelle laterali motivi floreali.
Le decorazioni sfruttano motivi non rigidamente neoclassici che rendono, insieme alle diverse colorazioni, meno rigorosi e complessivamente più gioiosi, gli altari; più rispettosi dei canoni neoclassici invece i due altari nel transetto sui cui architravi si stendono festoncini d'alloro. Gli effetti marmorei sono risolti ad encausto (tecnica pittorica che consiste nell'uso di colori diluiti con cera fusa e applicata a caldo).
AI 1930 risalgono invece le decorazioni della volta a botte della navata centrale che sono del pittore Barbieri di Parma e raffigurano negli angoli i quattro profeti maggiori, Isaia, Geremia, Daniele, Ezechiele, mentre al centro è rappresentata la Trinità.
Le statue della Madonna e di S. Giuseppe sono tipici gessi tardoottocenteschi di bella fattura.
Così si può dire anche per i santi Abdon e Sennen dei quali l'ancona ripropone lo stesso schema: colonne, architrave con cimasa curvata.
Le cantorie non sfuggono al medesimo schema; esse sono state disegnate dallo stesso Voghera, così come il frontale dell'organo; lo strumento datato 1840 è un Montesanti, maestro organaro mantovano.
ICONOGRAFIA DEVOZIONALE
Dalla chiesa vecchia demolita provengono: la balaustra, realizzata aggiungendo alla centrale quella dei due altari laterali preesistenti; l'altare, opportunamente allargato con materiali tombali policromi al cui centro è riprodotto l'ostensorio della parrocchia, opera di scuola mantovana del XVII secolo; ancora dalla vecchia chiesa proviene la vasca battesimale in marmo datata 1694.
L'iconografia connessa al culto e all'identificazione degli altari si avvale di alcuni dipinti di un certo decoro: sono, in genere, quadri provenienti dalla chiesa preesistente e di scuola locale. I più interessanti sono quelli riconducibili, sia pur attraverso incerte attribuzioni, ai pittori A. Bonisoli, R.De Longe, C. Urbino.
A sinistra nel transetto Lo sposalizio della Madonna è attribuito al Bonisoli, così come, con minore certezza, le due tele raffiguranti l'estasi di S. Francesco e S. Ignazio di Loyola.
Agostino Bonisoli nacque a Cremona nel 1635, morì nel 1707 a Tornata, dove risiedette per un certo periodo e dove è sepolto, secondo la sua volontà, sotto l'altare dell'affresco della Madonna col Bambino. Bonisoli fu per 28 anni pittore di corte dei Gonzaga di Bozzolo, più precisamente del principe Francesco. Evidenzia una propensione per il classicismo. Dopo aver studiato coi maestri Tortiroli, Miradori e Jacopo Ferrrari, si ispirò solo al veneto Paolo Veronese specialmente per il modo di dipingere le vesti e di arruffare barba e capelli, o di usare colori con effetti serici, rapporti preziosi.
A destra il quadro dei SS. Abdon e Sennen di anonimo del XVI sec. che fungeva da pala dell'altare maggiore della chiesa precedente. AI centro della tela sono rappresentate le belve feroci che, miracolosamente, non attaccano i due martiri.
A seguire, dopo la statua di S. Giuseppe, un quadro di anonimo con S. Antonio da Padova, probabilmente un ex voto, risalente al 1650 circa.
Nella successiva cappella, detta di S.Antonio, troviamo un quadro di autore ignoto del XVII secolo: La Sacra famiglia e S. Antonio, già della vecchia chiesa.
Il secondo altare è dedicato a S. Gaetano da Tiene la cui devozione viene dalla soppressione dei Teatini che avevano in Casteldidone una casa con scuola ed ospedale e gestivano i beni del Consorzio di S. Omobono (nel sec. XVII).
L'ultimo - o il primo - altare a destra è dedicato a S. Giovanni Bosco che compare in una tela del pittore Palmiro Vezzoni di Rivarolo del Re risalente agli anni '60. Del medesimo pittore, che ha lavorato anche per altre chiese della zona, la decorazione e le figure di Santa Maria Goretti e San Domenico Savio, dipinti su supporto di masonite inchiodata alle pareti laterali.
Sulla controfacciata due dipinti attribuiti a Roberto De Longe: Le nozze di Cana e La caduta della manna.
Roberto de Longe domina con Angelo Massarotti, Francesco Bocaccino, Bernardino Dehò, Giacomo Guerrini il panorama pittorico della zona. Nato a Bruxelles nel 1646, è detto il Fiamminghino. A 12 anni viene in Italia: Firenze, Genova, Venezia, Roma, Milano, Cremona dove affrescò chiese della città: Battistero, S. Sigismondo. Si pensa che siano andate perdute molte opere, però ne è riemersa recentemente una: la volta della chiesa della caserma Manfredini, (ex convento di S Salvatore, in zona S. Ilario), una bella volta affrescata. Secondo il Lanzi avrebbe anche frequentato la scuola di nudo di Agostino Bonisoli, presso la corte gonzaghesca di Bozzolo. Morì nel 1700 a Piacenza dove si era recato nel 1685 per lavori. A Solarolo Monasterolo c'è una grande composizione sua che rappresenta Anania che battezza Saul.
Nella cappella del battistero abbiamo una tela con cornice dell'800 col Battesimo di Gesù ed un'Ultima Cena attribuita alla scuola di Carlo Urbino da Crema, un pittore del XVI sec. molto leggiadro e facile nel disegno; collabora con Bernardino Campi allora molto impegnato (nella chiesa di San Marco a Milano e nel duomo di Cremona). Fornisce disegni per composizioni avendo molta fantasia immaginativa, si distingue per l'animazione delle figure viste in grande varietà di pose: figure sottilmente cadenzate, animate, prerogative che mancavano allo stesso Campi e che il pittore esegue con poche varianti pur perfezionandone la preziosità e le calligrafiche sottigliezze. Molti i suoi lavori grafici: disegni per ante d'organi, gonfaloni, stendardi, prontuari di figure maschili, femminili, di armi, di trofei...
Opere di Carlo Urbino sono a Crema in diverse chiese, a Pavia, alla Certosa e al Broletto, a Milano in S. Eustorgio, in S. Marco, in Santa Maria della passione, Santa Maria della scala. Suoi anche molti disegni per le vetrate del duomo.
L'altare successivo è dedicato a Sant'Agnese.
Nella Cappella "detta del Crocifisso" un quadro del XVII secolo L'Immacolata e San Francesco d'Assisi, proveniente dalla chiesa vecchia, ed un crocefisso, scultura lignea del XVI-XVII secolo, proveniente dall'Oratorio del Palazzo.